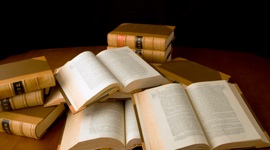
Termini di decadenza dal potere di accertamento e di riscossione degli atti impositivi
INDICE
1 Premessa………………………………………………………………………………………………………….. 3
2 Avvisi di accertamento (imposte sui redditi e IVA)………………………………………. 4
2.1 Dichiarazione rettificativa……………………………………………………………………………. 4
2.2 Rilascio della certificazione tributaria………………………………………………………….. 4
2.3 Regimi premiali per favorire la trasparenza (DL 201/2011)…………………………….. 5
3 Termini pendenti al 31.12.2011 (proroga di un anno per l’IVA)………………….. 6
4 Raddoppio dei termini per violazioni penali………………………………………………….. 6
4.1 Decorso del termine e rinvenimento della violazione penale……………………………. 8
4.2 Obbligo di denuncia…………………………………………………………………………………….. 8
4.3 Obbligo di allegazione della denuncia all’accertamento…………………………………. 9
4.4 rapporti con il procedimento penale……………………………………………………………. 10
4.5 Ampiezza dell’ulteriore azione accertatrice…………………………………………………. 10
4.6 Proroga dei termini e autore della violazione………………………………………………. 11
4.7 Periodo d’imposta oggetto della proroga…………………………………………………….. 11
5 Attività detenute in “paradisi fiscali”…………………………………………………………… 13
6 Avvisi di recupero dei crediti d’imposta………………………………………………………. 13
6.1 Recupero di crediti inesistenti indebitamente compensati………………………………. 14
6.2 Crediti d’imposta istituiti dalla legislazione speciale……………………………………. 14
7 Altri tributi……………………………………………………………………………………………………… 15
7.1 IRAP…………………………………………………………………………………………………………. 15
7.2 Imposte di registro, ipotecaria e catastale……………………………………………………. 15
7.3 Imposta sulle successioni e donazioni………………………………………………………….. 16
7.4 Tributi locali…………………………………………………………………………………………….. 16
8 Agevolazioni “prima casa”……………………………………………………………………………. 16
8.1 Dies a quo…………………………………………………………………………………………………. 16
8.2 Mendacio originario………………………………………………………………………………….. 17
8.3 Mendacio successivo………………………………………………………………………………….. 17
8.4 Immobile in costruzione……………………………………………………………………………… 18
9 Sanzioni amministrative………………………………………………………………………………… 18
10 Cartelle di pagamento………………………………………………………………………………….. 18
10.1 Cartella di pagamento emessa a seguito di sentenza……………………………………. 19
10.2 Imposte indirette diverse dall’IVA……………………………………………………………… 20
11 Tabelle riepilogative…………………………………………………………………………………….. 21
1 premessa
I provvedimenti impositivi devono essere notificati entro termini previsti a pena di decadenza, e ciò vale sia per gli avvisi di accertamento che per le cartelle di pagamento.
Il mancato rispetto dei termini comporta la nullità insanabile dell’atto.
La procedura impositiva è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali.
Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora[1].
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali[2].
L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Come si evidenzierà nel corso della trattazione, occorre vagliare l’assenza di cause di proroga dei termini.
Si pensi al DL 223/2006, che ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni penali constatate dai verificatori, o all’approvazione dei decreti di irregolare funzionamento degli uffici tributari, per effetto dei quali tutti i termini vengono prorogati per un periodo di oltre due mesi[3], o ancora alla proroga biennale per i contribuenti che non si sono avvalsi dei condoni di cui alla L. 289/2002[4].
Perfezionamento della notifica
Con la sentenza 23.1.2004 n. 28, la Corte Costituzionale ha enunciato il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore: pertanto, è a tale momento che occorre riferirsi per verificare il rispetto del termine decadenziale[5].
Di conseguenza, il termine deve ritenersi rispettato qualora, sebbene l’accertamento sia stato ricevuto dal contribuente ad esempio in data 3.1.2014, il provvedimento è stato consegnato al notificatore al più tardi il 31.12.2013[6].
Quanto esposto non vale solo per gli avvisi di accertamento, ma per tutti i provvedimenti impositivi, incluse le cartelle di pagamento.
2 avvisi di accertamento (imposte sui redditi e iva)
Per le imposte sui redditi e per l’IVA, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, salvo cause di proroga, entro il 31.12.2013 devono essere notificati gli atti concernenti il periodo d’imposta 2008.
Ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/73, l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La stessa disposizione è prevista nell’art. 57 del DPR 633/72, con riferimento all’IVA.
Pertanto, entro il 31.12.2013 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2008 (UNICO 2009).
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi che per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In tal caso, entro il 31.12.2013 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2007 (UNICO 2008).
2.1 dichiarazione rettificativa
L’art. 2 del DPR 322/98 prevede la possibilità di presentare dichiarazioni integrative, sia a favore del contribuente che a favore dell’Erario.
In queste ipotesi, occorre interrogarsi sugli effetti che tale dichiarazione comporta sui termini di decadenza.
L’Amministrazione finanziaria ha sottolineato come, per effetto della presentazione di dichiarazioni rettificative, “non è previsto dalla legge alcun allungamento dell’ordinario termine di decadenza relativo all’accertamento”[7].
Per contro, posto che l’art. 43 del DPR 600/73 collega il decorrere del termine al momento in cui la dichiarazione è stata presentata senza riferimento alla differenza tra dichiarazione originaria e rettificativa, si potrebbe sostenere che il termine debba decorrere dalla presentazione della dichiarazione rettificativa medesima.
In giurisprudenza, è stato sostenuto che la presentazione di dichiarazioni rettificative non ha alcun effetto sui termini decadenziali, siccome nessuna norma contempla la loro proroga a causa di tale dichiarazione[8].
Da ultimo, la circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31 ha precisato, con riferimento alla specifica ipotesi della dichiarazione integrativa presentata per “correggere” errori sull’imputazione di elementi positivi e negativi in base alla competenza fiscale, che, in relazione agli elementi oggetto di integrazione, i termini di decadenza devono essere computati con riferimento alla dichiarazione integrativa.
2.2 rilascio della certificazione tributaria
Una disciplina particolare è prevista per l’accertamento fondato sugli studi di settore in ipotesi di rilascio della “certificazione tributaria” (c.d. “visto pesante”).
Nella suddetta fattispecie, infatti, l’atto va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata[9].
2.3 regimi premiali per favorire la trasparenza (DL 201/2011)
L’art. 10 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, ha introdotto due regimi fiscali privilegiati per determinate categorie di contribuenti, i quali, tra l’altro, hanno l’effetto di ridurre di un anno il termine di decadenza dal potere di accertamento.
Pertanto, per i soggetti che possono fruire della suddetta normativa, l’avviso di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione[10].
La norma prevede espressamente che, nell’ipotesi di constatazione di elementi penalmente rilevanti, rimane fermo il termine di decadenza ordinario, in tale fattispecie raddoppiato[11].
In breve, l’art. 10 del DL 201/2011 ha introdotto due regimi fiscali privilegiati:
- un primo, fruibile dai soggetti che svolgono attività artistica o professionale o attività d’impresa in forma individuale o con le forme associative ex art. 5 del TUIR, che, tra l’altro, presuppone che il contribuente invii telematicamente all’Amministrazione finanziaria i corrispettivi e le fatture emesse/ ricevute e istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dedicati all’attività esercitata[12];
- un secondo, che concerne i contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di settore, che presuppone, fra l’altro, la dichiarazione di ricavi/compensi almeno pari a quelli derivanti dall’applicazione degli studi stessi e il corretto assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in tema di studi di settore[13].
Decorrenza
Il DL 201/2011 prevede una diversa decorrenza dei suddetti due regimi privilegiati, e ciò ha riflesso sul periodo d’imposta con riferimento al quale si applica il minor termine di decadenza dal potere di accertamento.
Nello specifico:
- per il regime disciplinato dall’art. 10 co. 1 – 8 del DL 201/2011, la nuova normativa opera a partire dall’1.1.2013, quindi il riflesso sul termine di accertamento si avrà con riferimento ai controlli sui periodi d’imposta 2013 e successivi;
- per il regime disciplinato dall’art. 10 co. 9 – 13 del DL 201/2011 (concernente i contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di settore), il nuovo regime si applica a partire dalle dichiarazioni relative all’anno 2011, quindi da UNICO 2012; per questo motivo, in costanza dei presupposti di legge, il minor termine opera già a partire dagli accertamenti sul periodo d’imposta 2011[14].
3 termini pendenti al 31.12.2011 (proroga di un anno per l’iva)
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 138/2011, i termini di decadenza pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di un anno limitatamente all’IVA e per i contribuenti che hanno aderito alle sanatorie di cui alla L. 289/2002.
Il DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148, all’art. 2 co. 5-ter, ha stabilito che, in riferimento all’IVA e per i soggetti che si sono avvalsi delle sanatorie introdotte dalla L. 289/2002, i termini di decadenza dal potere di accertamento che erano pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di un anno[15].
Pertanto, l’annualità 2006, che, ordinariamente, sarebbe decaduta il 31.12.2011, per effetto di tale norma è decaduta il 31.12.2012[16].
Occorre rammentare che, in base ad una ulteriore interpretazione, addirittura l’anno 2002 potrebbe essere oggetto di proroga, per le seguenti considerazioni:
- ordinariamente, il periodo d’imposta 2002 è decaduto il 31.12.2007;
- in presenza di indizi di reato, i termini di decadenza sono raddoppiati, quindi, se il reato è stato commesso nel 2002, l’annualità è decaduta il 31.12.2011;
- per effetto della proroga di un anno introdotta dal DL 138/2011, l’annualità 2002 è decaduta non il 31.12.2011, ma il 31.12.2012.
Tuttavia, osta a questa conclusione la sentenza della Corte Costituzionale 25.7.2011 n. 247, ove i giudici hanno espressamente sancito che la proroga dei termini da reato non si cumula con nessuna altra disposizione, presente o futura, che contempli anch’essa una proroga di termini: per questo motivo, il periodo d’imposta 2002 rimarrebbe decaduto al 31.12.2011[17].
4 raddoppio dei termini per violazioni penali
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 223/2006 agli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, in ipotesi di constatazione di violazioni penalmente rilevanti, i termini per l’accertamento sono raddoppiati con riferimento all’anno in cui è stata commessa la violazione.
L’art. 43 co. 2-bis del DPR 600/73 sancisce che, in caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso.
Nelle ipotesi sopra prospettate, l’Agenzia delle Entrate può quindi notificare l’accertamento entro il 31 dicembre:
- dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla[18].
Va subito detto che la proroga dei termini per violazioni penali non può essere sommata a nessun’altra disposizione che preveda, anch’essa, una proroga dei termini, a meno che non sia la legge medesima a statuire diversamente[19]. Così, non è possibile che detto raddoppio si cumuli con la proroga biennale di cui all’art. 10 della L. 289/2002 per mancata adesione ai condoni, né con l’art. 2 co. 5-ter del DL 138/2011 (norma istituita nello specifico per l’IVA)[20], mentre a conclusioni diverse si deve giungere per i termini relativi alla compensazione di crediti inesistenti, in quanto il cumulo è ammesso dall’art. 27 del DL 185/2008[21].
Evasioni relative a comparti impositivi differenti
Qualora l’accertamento si riferisca, per esempio, a imposte sui redditi, IRAP e IVA, l’astratta configurabilità di un reato derivante da potenziale evasione delle imposte sui redditi comporterà il raddoppio dei termini per tali tributi, ma mai ad esempio per l’IRAP, la cui evasione non ha rilievo penale.
Invece, per l’IVA, occorrerà che, prima l’Agenzia e poi il giudice, vaglino la sussistenza degli estremi di un reato rilevante anche ai fini di tale imposta, posto che la proroga opera, in assenza di indicazioni normative contrarie, solo per il tributo cui il reato si riferisce[22].
Pertanto, in tali ipotesi, l’accertamento emesso dopo il decorso degli ordinari termini per l’accertamento dovrebbe automaticamente essere annullato per l’IRAP, confermato, in merito ai termini, per le imposte sui redditi e, se del caso, per l’IVA.
In generale, la proroga non opera per le fattispecie evasive che non hanno rilievo penale, oppure che comportano la sussistenza di reati non previsti dal DLgs. 74/2000, quindi, a titolo esemplificativo, il raddoppio dei termini non si verifica per gli illeciti concernenti:
- violazioni valutarie e doganali;
- determinati comportamenti del contribuente in occasione delle verifiche fiscali[23];
- inosservanza della normativa in tema di monitoraggio fiscale (modulo RW)[24];
- evasione di imposte indirette diverse dall’IVA (es. imposte di registro, successione e donazione).
L’inapplicabilità del raddoppio per l’IRAP è stata confermata da C.T. Prov. Verbania 6.5.2011 n. 31/1/11, mentre per altra giurisprudenza esso trova applicazione in quanto l’art. 25 del DLgs. 446/97 rinvia, in punto accertamento, al DPR 600/73[25].
Studi di settore
La proroga non dovrebbe riguardare gli accertamenti basati sugli studi di settore in quanto, in tale ipotesi, l’ufficio è esonerato dall’obbligo di denuncia anche in caso di superamento delle soglie di punibilità previste dal DLgs. 74/2000[26].
Tale affermazione verrebbe meno ove si optasse per la tesi che lega il raddoppio all’astratta sussistenza del reato, a prescindere dall’avvenuta denuncia, e, quindi, da un obbligo in tal senso.
4.1 decorso del termine e rinvenimento della violazione penale
Il DL 223/2006 non ha specificato se il rinvenimento degli elementi penalmente rilevanti possa o meno essere idoneo a cagionare il raddoppio dei termini ove si concretizzi in un momento in cui i termini per l’accertamento siano già decaduti.
Il testo normativo si presta ad entrambe le interpretazioni, anche se la “riapertura” dei termini si tradurrebbe, a nostro avviso, in un’indiscriminata posizione di vantaggio per gli uffici.
Per questo motivo, C.T. Prov. Napoli 29.4.2010 n. 266 ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 57 del DPR 633/72 (ma il discorso è analogo per l’art. 43 del DPR 600/73), nella parte in cui non subordina il raddoppio al fatto che la denuncia ex art. 331 c.p.p. sia stata inviata antecedentemente allo spirare dei termini di decadenza.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 25.7.2011 n. 247, si è espressa in senso sfavorevole nei confronti del contribuente, affermando che il raddoppio dei termini è cagionato da un fattore obiettivo, rinvenibile nell’obbligo di presentazione della denuncia, per cui il legislatore ha introdotto non un raddoppio di termini ma un nuovo termine di decadenza, applicabile in presenza della circostanza citata. Alla luce di quanto esposto, non ha rilievo che la denuncia penale sia inviata in un momento in cui gli ordinari termini di decadenza erano oramai spirati.
Occorre evidenziare che l’orientamento richiamato, accolto dalla Cassazione[27], non è stato condiviso da parte della giurisprudenza di merito, secondo cui qualora gli elementi penalmente rilevanti siano stati rinvenuti a termini decaduti, il raddoppio non può operare[28].
4.2 Obbligo di denuncia
L’obbligo di invio della denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. è la circostanza che legittima il termine raddoppiato.
Nella sentenza Corte Cost. 25.7.2011 n. 247 si rammenta che si tratta di una condizione obiettiva, quindi perde di rilievo l’affermazione secondo cui l’applicabilità del raddoppio può essere frutto di decisioni arbitrarie dei funzionari.
Peraltro, tale evenienza, secondo i giudici, sarebbe scongiurata da due circostanze:
- l’obbligo, sanzionato penalmente ex art. 361 c.p., di inoltrare “senza ritardo” la denuncia, incombente sui verificatori sia della Guardia di Finanza che dell’Agenzia delle Entrate;
- la possibilità, per la Commissione tributaria, di vagliare autonomamente la presenza dell’obbligo di denuncia, e, di conseguenza, la facoltà di disconoscere l’applicabilità del termine raddoppiato.
L’evenienza, messa in risalto nell’ordinanza di rimessione, che il raddoppio possa essere ritenuto operante dai verificatori in presenza di elementi puramente indiziari ed enfatizzati, è scongiurata dal fatto che i requisiti per l’obbligo di denuncia sono obiettivi, e non possono dipendere da una valutazione soggettiva dei funzionari.
In effetti, questo è il passo più preoccupante della sentenza: talvolta, non è chiaro se una certa fattispecie possa o meno integrare gli estremi di un delitto tributario, e il funzionario, per eccesso di zelo o magari per evitare il rischio di commettere, a sua volta, il delitto di omessa denuncia, potrebbe essere indotto a segnalare fatti che, per le circostanze del caso, difficilmente avrebbero rilievo penale.
Sul punto, la Corte Costituzionale mette in risalto che l’obbligo è presente quando il pubblico ufficiale “sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare (escluse le cause di estinzione e di non punibilità, che possono essere valutate solo dall’autorità giudiziaria), non essendo sufficiente un generico sospetto di attività illecita”.
L’aspetto che dovrebbe garantire piena tutela al contribuente è la possibilità, in capo alla Commissione tributaria, di vagliare in via incidentale la presenza degli estremi per l’obbligo di denuncia.
Infatti, il giudice investito dell’impugnazione deve considerare, mediante un giudizio di “prognosi postuma”, la ricorrenza dei seri indizi di reato, “accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento”.
Concludendo, nella sentenza si specifica che:
- se la contestazione circa l’applicabilità del raddoppio viene sollevata dal contribuente, è onere dell’Amministrazione finanziaria giustificare il più ampio termine;
- il tema di prova è comunque circoscritto alla presenza degli estremi per l’obbligo di denuncia, e non riguarda l’accertamento del reato[29].
Quest’ultima affermazione desta non poche perplessità.
La Commissione tributaria non potrà, accogliendo la tesi della Corte Costituzionale, ritenere inoperante la proroga sulla base di circostanze aventi rilievo solo penalistico, quali la presenza di obiettiva incertezza sulla norma[30] o l’assenza di dolo specifico in capo al contribuente.
La giurisprudenza di merito, comunque, pare aver interpretato il principio della Consulta privilegiandone la ratio; infatti, è stato sostenuto che:
- la Commissione tributaria deve accertare, mediante la c.d. “prognosi postuma”, se, all’epoca dei fatti, sussisteva l’obbligo di invio della denuncia penale e, se l’eccezione di inapplicabilità della proroga viene sollevata dal contribuente, l’onere di dimostrare la presenza dei seri indizi di reato è in capo all’Agenzia delle Entrate (caso concernente una contestazione sulla violazione della competenza fiscale che, ai fini penali, avrebbe dovuto riguardare poste passive fittizie, che avrebbero integrato il delitto di dichiarazione infedele)[31];
- il raddoppio non opera in caso di indebito riporto di perdite d’impresa per effetto del mancato “affrancamento” in sede di condono ai sensi dell’art. 9 co. 7 della L. 289/2002, siccome il delitto di dichiarazione infedele non è presente nella specie, non essendovi alcuna posta passiva fittizia come richiesto dall’art. 4 del DLgs. 74/2000[32];
- non vi può essere raddoppio dei termini nel caso del c.d. “abuso del diritto”[33];
- non può avere alcun rilievo una denuncia a carattere “esplorativo”[34].
4.3 Obbligo di allegazione della denuncia all’accertamento
Al fine di effettuare il giudizio sulla c.d. “prognosi postuma”, il giudice tributario deve esaminare la denuncia presentata dall’Amministrazione finanziaria, non essendo sufficiente un semplice richiamo alla stessa. In altri termini, la denuncia deve essere allegata agli atti, pena la nullità dell’accertamento per tardività[35].
Per Corte Cost. 25.7.2011 n. 247, la proroga opera quando sono presenti gli estremi per l’inoltro della denuncia, a prescindere dal fatto che questa sia stata effettivamente inviata.
Invero, tale affermazione si porrebbe in contrasto con quanto sancito dalla giurisprudenza di merito richiamata, ma non può essere revocato in dubbio che talvolta il giudice tributario, per poter verificare se l’Amministrazione abbia o meno utilizzato il raddoppio in maniera pretestuosa, deve poter visionare la denuncia presentata.
Denuncia penale e diritto di accesso agli atti amministrativi
La denuncia penale può essere oggetto di richiesta di accesso agli atti amministrativi, in quanto sussiste un interesse qualificato alla sua visione[36].
Infatti, tale denuncia costituisce il presupposto di applicabilità del raddoppio dei termini. La questione sarebbe diversa ove il contribuente avesse chiesto di visionare gli atti di indagine, coperti dal segreto istruttorio, tra i quali non rientra la denuncia.
4.4 rapporti con il procedimento penale
I rapporti tra il procedimento penale e il contenzioso tributario sono governati dal c.d. “doppio binario” ex art. 20 del DLgs. 74/2000, per cui il contribuente può essere condannato dal Tribunale e, nel contempo, essere “assolto” dalla Commissione tributaria.
Ciò è vero, quindi è innegabile che l’assoluzione/archiviazione/non luogo a procedere del contribuente non comportano, automaticamente, l’infondatezza dell’accertamento, ma non può essere dimenticato che la pronuncia penale deve essere vagliata, in maniera critica, dalla Commissione tributaria.
Potrebbe accadere che un contribuente riceva un accertamento nel termine “lungo” avente “rilievo penale”, e che la tesi accusatoria si concluda subito con un’archiviazione, per fatti che hanno rilievo sia penale sia fiscale.
In queste ipotesi, ben possono sussistere gli estremi per l’obbligo di denuncia, ma, per questioni “comuni ad entrambe le giurisdizioni”, la condotta si riveli del tutto lecita.
C.T. Prov. Torino 8.6.2011 n. 97/15/11 ha stabilito che se il GIP ha disposto l’archiviazione del reato per infondatezza della denuncia, la proroga non opera, poiché se il fatto non costituisce reato non può ritenersi sussistente nemmeno l’obbligo di denuncia[37].
Nel senso che il raddoppio opera nonostante il decreto di archiviazione del reato, in quanto non è presente alcuna “pregiudiziale penale”, si veda C.T. Prov. Treviso 11.4.2012 n. 44/1/12.
Prescrizione del reato
La prescrizione del reato non dovrebbe avere rilievo in merito all’applicabilità del raddoppio dei termini, in quanto circostanza “propria” del processo penale.
Invece, C.T. Prov. Vicenza 14.3.2012 n. 34/1/12 e C.T. Prov. Padova 18.6.2013 n. 85/5/13 hanno affermato che se il reato è prescritto viene meno il presupposto per il raddoppio.
4.5 ampiezza dell’ulteriore azione accertatrice
Allo stato attuale, non constano pronunce giurisprudenziali sull’ampiezza del potere di accertamento derivante dalla constatazione di elementi penalmente rilevanti[38].
Secondo la Guardia di Finanza[39] e Assonime[40], una volta sussistente il presupposto per la proroga, l’accertamento, in relazione ai periodi “prorogati”, potrebbe concernere l’intera posizione fiscale del contribuente, e non solo i fatti oggetto della violazione penale.
4.6 Proroga dei termini e autore della violazione
Potrebbero sorgere dubbi sull’ambito di applicazione della norma se l’autore del reato non coincide con il contribuente, come nei casi di:
- reati commessi al fine di consentire a terzi di evadere[41];
- omissione di versamento di ritenute[42].
In quest’ultima ipotesi, la violazione, commessa dal sostituto, riguarda l’imposta dovuta dal sostituito, quindi il raddoppio dei termini (nei confronti del sostituto) sarebbe destituito di fondamento.
Nell’attesa di interventi della giurisprudenza sul punto, si potrebbe sostenere che, in tal caso, la proroga operi solo per gli accertamenti, eseguiti nei confronti del sostituto, relativi all’omessa esecuzione delle ritenute fiscali, oppure per gli accertamenti riguardanti la posizione fiscale del sostituito notificati, però, al sostituto[43].
4.7 periodo d’imposta oggetto della proroga
Il DL 223/2006 ha circoscritto la proroga al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione, creando in tal modo varie problematiche, derivanti dal fatto che, spesso, il delitto si perfeziona in un esercizio diverso da quello in cui è avvenuta la violazione della legge fiscale.
L’ipotesi più lampante concerne la dichiarazione infedele, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione. Così, applicando alla lettera la norma, in una fattispecie relativa al periodo d’imposta 2012, il reato si perfeziona con l’invio di UNICO 2013, e sarebbe il 2013 a dover subire il raddoppio dei termini.
Stante l’irrazionalità di ciò, si è prospettato di interpretare teleologicamente la norma, giungendo alla conclusione che in tal caso, come nell’omessa dichiarazione, il periodo d’imposta coinvolto dalla proroga dovrebbe essere sempre quello fiscalmente rilevante, quindi, nel nostro caso, il 2012.
In altre ipotesi, tuttavia, tale operazione ermeneutica sarebbe più difficile. Nella distruzione di documenti contabili[44], il reato potrebbe essere commesso nel 2012, in merito a documenti inerenti, per ipotesi, il 2008, oppure il 2009 e il 2010.
Ancora, si pensi al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte[45], caso in cui il raddoppio dovrebbe essere inapplicabile, alla luce del fatto che esso opera solo con riferimento all’anno in cui il reato è stato commesso. Avrebbe poco senso che per la sottrazione fraudolenta commessa ad esempio nel 2006, subisca il raddoppio tale anno, visto che il reato nulla ha a che vedere con le irregolarità fiscali verificatesi in quest’ultimo periodo d’imposta, e magari è stato commesso per eludere il versamento di imposte concernenti anni pregressi, in alcun modo raddoppiabili, stante il tenore della norma.
Specie in merito all’ultima fattispecie, urge un intervento del legislatore.
4.8 redditi prodotti in forma associata
L’art. 43 del DPR 600/73 non specifica se il raddoppio dei termini possa operare anche ove il maggior reddito sia accertato in capo ad una società di persone, soggetta al regime della trasparenza[46].
Adottando la soluzione affermativa, l’Agenzia delle Entrate potrebbe, una volta notificato l’accertamento alla società, beneficiare del maggior termine anche per la notifica dell’atto ai singoli soci.
Sulla questione si è pronunciata la C.T. Prov. Treviso 2.12.2010 n. 112, ove i giudici sostengono che i rilievi penali constatati in capo alla società a seguito di accertamenti IRPEF non hanno, dal punto di vista del raddoppio, automatico rilievo rispetto ai soci, con la conseguenza che gli accertamenti notificati a questi ultimi devono sottostare all’ordinario termine quadriennale.
Infatti, nonostante, dal punto di vista fiscale, i redditi siano attribuiti mediante trasparenza, occorre valutare la sussistenza di una responsabilità penale in capo ai soci[47].
Il criterio interpretativo fatto proprio dai giudici comporterebbe il seguente effetto.
Potrebbe accadere che, in una società di quattro soci, il raddoppio, in capo a questi ultimi, si verifichi solo se sussiste la responsabilità penale, quindi, ad esempio, solo nei confronti del socio amministratore. Pertanto, ove l’Agenzia delle Entrate notifichi gli accertamenti oltre il termine ordinario, sarà tempestivo solo quello notificato nei confronti del socio amministratore, e saranno tardivi gli altri.
Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali “ristrette”
Alla medesime conclusioni la giurisprudenza è pervenuta per il caso degli accertamenti basati sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali “ristrette”.
È stato infatti affermato che il raddoppio non opera per i soci di società di capitali “ristrette” ove la denuncia sia stata inoltrata per fatti imputabili all’amministratore della società[48].
4.9 Consolidato fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.12.2009 n. 54, ha specificato che, in determinate ipotesi, la peculiarità della fattispecie impositiva comporta l’estensione della proroga nei confronti di soggetti diversi da quello “accertato”, ma legati a quest’ultimo ad esempio da un vincolo solidale.
La circolare menziona il consolidato fiscale[49], la trasparenza fiscale[50] e la liquidazione IVA di gruppo[51].
Nonostante su ciò non vi siano ancora pronunce della giurisprudenza, si ritiene che l’ambito di applica-zione della proroga debba essere vagliato in riferimento alla peculiarità della tassazione consolidata.
Pertanto, il rinvenimento di violazioni penali in capo alla società consolidata dovrebbe comportare il raddoppio anche nei confronti della società consolidante; in caso contrario, il raddoppio sarebbe pressoché inapplicabile, visto che l’accertamento sulla singola consolidata è destinato a riflettersi necessariamente sul modello CNM.
5 attività detenute in “paradisi fiscali”
Nelle rettifiche relative alla c.d. “presunzione di imponibilità” delle somme detenute in “paradisi fiscali”, i termini per l’accertamento sono raddoppiati.
L’art. 1 co. 3 del DL 30.12.2009 n. 194, conv. L. 26.2.2010 n. 25, inserendo i co. 2-bis e 2-ter all’art. 12 del DL 1.7.2009 n. 79 conv. L. 3.8.2009 n. 102, ha introdotto il raddoppio dei termini per:
- l’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 co. 1, 2 e 3 del DL 28.6.90 n. 167 conv. L. 4.8.90 n. 227, per le attività detenute nei c.d. “paradisi fiscali”;
- l’applicazione della presunzione di cui all’art. 12 co. 2 del suddetto DL 1.7.2009 n. 79 conv.
L. 3.8.2009 n. 102.
Ai sensi dell’art. 12 co. 2 del DL 78/2009, le attività di natura finanziaria e/o gli investimenti detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 co. 1, 2 e 3 del DL 167/90 si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
Decorrenza
Per l’operatività della suddetta disposizione non è stata prevista una specifica decorrenza.
Essa potrebbe trovare applicazione per tutti i periodi d’imposta per i quali risultano ancora pendenti i termini per gli accertamenti alla data di entrata in vigore del DL 194/2009, ossia al 30.12.2009.
In particolare, per gli accertamenti disciplinati dall’art. 43 del DPR 600/73, il raddoppio dei termini si produrrebbe a partire dal periodo d’imposta 2004, oppure dal 2003 in caso di dichiarazione omessa[52].
Una diversa interpretazione muove invece dall’art. 3 della L. 27.7.2000 n. 212 (Statuto del contribuente), secondo cui le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo.
Applicando tale disposizione, il raddoppio dei termini non potrebbe trovare applicazione per i periodi d’imposta precedenti al 2009 (anno di entrata in vigore del DL 194/2009).
La prima giurisprudenza pronunciatasi sul tema ha affermato che la presunzione di imponibilità dei capitali illecitamente detenuti all’estero, proprio in virtù dell’art. 3 della L. 212/2000, non può essere applicata retroattivamente[53].
6 avvisi di recupero dei crediti d’imposta
I provvedimenti di recupero dei crediti d’imposta devono essere notificati entro termini decadenziali, al pari di quanto contemplato per gli avvisi di accertamento.
L’art. 1 co. 421 – 423 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) ha disciplinato i c.d. “avvisi di recupero dei crediti d’imposta”, i quali, anche antecedentemente all’avvento della suddetta legge, erano spesso utilizzati dagli uffici al fine di recuperare crediti d’imposta indebitamente fruiti, in assenza dei presupposti di legge.
Le ipotesi che possono spingere gli uffici all’utilizzo di tale strumento sono varie: si pensi, a titolo esemplificativio, al bonus “ricerca e sviluppo”, o al credito d’imposta per le assunzioni in aree svantaggiate.
Se l’avviso di recupero concerne crediti “inesistenti” utilizzati in compensazione, vige una speciale procedura delineata dall’art. 27 co. 18 – 20 del DL 29.11.2008 n. 185, conv. L. 28.1.2009 n. 2, molto più gravosa sia sul versante accertativo che esattivo.
6.1 recupero di crediti inesistenti indebitamente compensati
L’art. 27 co. 16 del DL 185/2008 ha inasprito le sanzioni per l’indebita utilizzazione di crediti inesistenti nel modello di pagamento unificato (F24)[54].
Gli uffici finanziari sono legittimati a notificare l’atto di recupero entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo[55].
Un’interpretazione particolarmente fedele al dato letterale porterebbe a sostenere che, ogniqualvolta si sia in presenza di un credito indebitamente compensato, l’atto di recupero possa essere notificato entro i più ampi termini stabiliti dall’art. 27 del DL 185/2008, e non entro l’ordinario termine quadriennale.
Adottando tale impostazione, il termine di otto anni sarebbe applicabile laddove, ad esempio, l’indebita compensazione fosse la conseguenza di accertamenti dell’Agenzia delle Entrate (si pensi al disconoscimento del diritto di detrazione IVA sulla base dell’inesistenza di operazioni, o agli accertamenti analitici derivanti dal riscontro tra dichiarazione, bilancio e scritture contabili).
Quanto esposto condurrebbe, di fatto, ad una surrettizia elusione dell’ordinario procedimento accertativo (artt. 38 ss. del DPR 600/73), siccome in un rilevante numero di ipotesi (ovvero in tutti i casi in cui la rettifica della dichiarazione abbia riflessi sull’avvenuta compensazione nel modello F24), l’Agenzia delle Entrate potrebbe fruire del maggior termine di otto anni per la notifica dell’atto di recupero[56].
Con l’intento di evitare una simile conclusione, si ritiene che l’art. 27 del DL 185/2008 possa essere applicato alle fattispecie in cui l’indebita compensazione derivi da crediti inesistenti in senso assoluto, ovvero non indicati in dichiarazione, ma indicati ed utilizzati solo nel modello F24.
Pertanto, al di fuori di questa fattispecie, rimarrebbero fermi gli ordinari procedimenti, per cui ove l’indebita compensazione derivi da un’artificiosa rappresentazione della realtà ad opera del contribuente (ad esempio, detrazione di IVA relativa a fattispecie indetraibili), il termine sarà quello contemplato dagli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72.
L’Agenzia delle Entrate, sebbene non in via ufficiale, sembra essersi espressa in senso opposto[57].
Per C.T. Prov. Bari 4.8.2010 n. 140, la norma fa riferimento ai crediti “inesistenti”, il che non coincide con la locuzione crediti “non spettanti”, mentre altra giurisprudenza ha ragionato in senso opposto[58].
6.2 crediti d’imposta istituiti dalla legislazione speciale
Stante la loro natura accertativa, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta devono essere notificati entro termini decadenziali[59].
Occorre pertanto il rispetto dei termini di cui all’art. 43 del DPR 600/73, e il termine ultimo previsto, a pena di decadenza, entro cui notificare l’atto può essere ricavato dall’art. 27 co. 18 del DL 185/2008, norma che riguarda la specifica ipotesi degli avvisi di recupero emessi per contrastare l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti inesistenti.
Quest’ultima disposizione prevede che l’avviso possa essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito, quindi, per gli avvisi “ordinari” (intendendosi per tali quelli emessi al di fuori del peculiare caso dei crediti inesistenti indebitamente compensati) il termine dovrebbe coincidere con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di utilizzo.
7 altri tributi
Anche per i tributi diversi dalle imposte sui redditi e dall’IVA, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro termini previsti a pena di decadenza.
Nei comparti impositivi diversi dalle imposte sui redditi e dall’IVA, i provvedimenti devono essere anch’essi notificati entro termini previsti a pena di decadenza, che variano a seconda del tributo nonché della fattispecie considerata.
Per la fiscalità locale, invece, i termini, sia per l’accertamento che per la riscossione, sono stati unificati per tutti i tributi dalla L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
7.1 IRAP
Nell’IRAP trovano applicazione i termini previsti per le imposte sui redditi, posto che l’art. 25 del DLgs. 446/97 rinvia, per l’accertamento, alla disciplina del DPR 600/73.
Del pari, l’art. 30 co. 6 del DLgs. 446/97 prevede che, in materia di riscossione, si applichino le norme previste per le imposte sui redditi, quindi la cartella di pagamento dovrà essere notificata entro i termini di cui all’art. 25 del DPR 602/73.
7.2 imposte di registro, ipotecaria e catastale
Per ciò che riguarda l’imposta di registro, il DPR 131/86 stabilisce che:
- l’imposta relativa agli atti che non sono stati presentati per la registrazione deve essere richiesta entro cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio[60];
- l’avviso di rettifica di maggior valore deve essere notificato entro due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale[61];
- salvo il caso relativo al punto precedente, l’imposta deve essere richiesta entro tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica[62]:
– dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
– dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’art. 19 del DPR 131/86 (eventi successivi alla registrazione), se si tratta di imposta complementare;
– dalla data di notifica della sentenza del giudice tributario ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva, qualora sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione o di rettifica;
– dalla data di registrazione dell’atto, in ipotesi di occultazione di corrispettivo;
– dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’art. 19 del DPR 131/86 (eventi successivi alla registrazione), se si tratta di imposta suppletiva.
Inoltre, ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis del DPR 131/86, introdotto dall’art. 8 co. 10 del DL 2.3.2012
n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, le somme relative al mancato pagamento dell’imposta di registro sulle locazioni in merito ad annualità successive alla prima, così come nel caso di cessioni, risoluzioni e proroghe, vanno richieste, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
Per le imposte ipotecaria e catastale valgono, in linea generale, i termini previsti per l’imposta di registro[63].
7.3 imposta sulle successioni e donazioni
Per l’imposta sulle successioni, l’art. 27 del DLgs. 346/90 prevede che:
- la liquidazione dell’imposta deve essere notificata entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa;
- la rettifica della dichiarazione infedele o incompleta deve essere notificata entro due anni dal pagamento dell’imposta principale;
- in caso di omissione della dichiarazione, l’avviso deve essere notificato entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione omessa.
L’art. 60 del DLgs. 346/90 stabilisce che, per l’imposta sulle donazioni, vale la normativa operante in tema di imposta di registro.
7.4 Tributi locali
La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato[64].
Invece, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo[65].
8 agevolazioni “Prima casa”
Il recupero delle agevolazioni “prima casa” va effettuato entro termini decadenziali, nello specifico entro il termine triennale di cui all’art. 76 del DPR 131/86, il cui ambito di applicazione, in riferimento a tale fattispecie, deve essere puntualmente delineato.
L’individuazione del termine per il recupero delle agevolazioni “prima casa” è stato oggetto di alcuni contrasti giurisprudenziali, i quali sono stati risolti ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza 21.11.2000 n. 1196, hanno chiarito che alla fattispecie in esame si applica il termine triennale di cui all’art. 76 del DPR 131/86 e non quello decennale di cui all’art. 78 del medesimo DPR.
8.1 Dies a quo
Come chiarito nella citata sentenza 1196/2000, la carenza di indicazioni legislative in relazione al decorso dei termini impone di applicare le norme comuni vigenti nell’ordinamento[66].
Pertanto, è necessario fare riferimento agli artt. 2946 ss. c.c., in forza dei quali il termine di decadenza inderogabilmente assegnato per porre in essere un determinato comportamento è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l’atto o il comportamento stesso.
Quindi, il termine decorre dal momento in cui l’ufficio si trovi nelle condizioni per contestare la perdita del trattamento agevolato[67].
Tale momento varia a seconda del tipo di dichiarazione resa nell’atto. Infatti, la mendacità delle dichiara-zioni rese in sede di rogito può manifestarsi con modalità differenti:
- il contribuente può aver dichiarato una condizione che non sussisteva già al momento della stipula del contratto (ad esempio, dichiarando falsamente di non possedere, nel Comune dove si trova l’immobile, alcun altro immobile), ponendo in essere il c.d. “mendacio originario”;
- oppure in conseguenza di eventi sopravventi, come avviene, ad esempio, nel caso in cui il soggetto dichiari che trasferirà la propria residenza nel Comune ove si trova l’immobile entro 18 mesi dal rogito, ma tale condizione non viene, poi, realizzata. Tali casi configurano ipotesi di “mendacio sopravvenuto”[68].
Il dies a quo del termine decadenziale è diverso a seconda che si verta in un’ipotesi di mendacio originario o di mendacio sopravvenuto.
8.2 Mendacio originario
Nel caso in cui il contribuente attesti falsamente in atto un elemento discordante dalla realtà riscontrabile al momento dell’atto stesso, il termine di decadenza triennale decorre dal momento stesso della registrazione, posto che l’ufficio può già verificare la mancanza delle condizioni per l’applicazione del trattamento agevolato.
In proposito, si veda Cass. 6.2.2009 n. 2950, ove si afferma che il termine decorre dalla data di registrazione se, al momento dell’atto, siano già sussistenti le circostanze che impediranno l’avverarsi delle condizioni dichiarate in atto dal contribuente.
8.3 Mendacio successivo
Ove la falsità dell’attestazione fatta in sede di rogito si manifesti successivamente, il termine di decadenza triennale decorre dal momento in cui si sia verificato l’evento in conseguenza del quale la mendacità si è rivelata.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente non trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dal rogito, il termine di decadenza triennale a disposizione dell’ufficio decorre dallo scadere del diciottesimo mese dall’acquisto. In pratica, il termine di decadenza per l’accertamento sarà di 4 anni e mezzo dal rogito.
Si ricorda che un’ulteriore causa di decadenza dal godimento dell’agevolazione prima casa è costituita dalla vendita dell’immobile prima del decorso di 5 anni dall’acquisto. La decadenza è impedita dall’acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla vendita infraquinquennale.
Posto che anche il verificarsi di tale decadenza è legata ad un evento (mancato riacquisto entro un anno dalla vendita) successivo all’acquisto agevolato, anche in tal caso la decorrenza del termine triennale per l’accertamento non può decorrere dal momento di registrazione dell’atto, bensì da un momento successivo, essendo impossibile accertare la decadenza già al momento dell’acquisto agevolato.
In particolare, il termine per l’accertamento, in tal caso, decorrerà dallo scadere dell’anno successivo alla vendita infraquinquennale.
Pertanto, in caso di vendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con l’agevolazione, la decadenza interverrà dopo 4 anni dall’atto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell’immobile acquistato con le agevolazioni.
8.4 Immobile in costruzione
L’acquisto di un immobile in costruzione configura una situazione nella quale può rivelarsi difficile applicare i principi su esposti.
Infatti, fino a che l’immobile non viene ad esistenza, non è possibile accertare la mendacità di alcune delle dichiarazioni effettuate in relazione ed esso, né verificare la sussistenza delle caratteristiche dell’immobile.
In particolare, è chiaro che, sino a che l’immobile non sia stato ultimato, è impossibile verificare se esso sia di lusso o meno, poiché le caratteristiche dell’immobile potrebbero ancora essere modificate.
Pertanto, applicando i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza 1196/2000, dovrebbe concludersi che l’ufficio decada dopo tre anni dal momento in cui l’accertamento della decadenza diviene possibile, ovvero dal giorno in cui l’immobile sia stato ultimato.
Tuttavia, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 12.8.2005 n. 38 (§ 5.1), per evitare il differimento all’infinito dei termini per la verifica delle condizioni per godere dell’agevolazione, è necessario stabilire un termine entro il quale il contribuente deve ultimare i lavori.
Infatti, in caso contrario, posto che la legge non fissa alcun termine entro il quale i lavori di costruzione debbano essere terminati, potrebbe accadere che l’Amministrazione non venga mai messa in condizione di verificare la decadenza dall’agevolazione (se i lavori non vengono ultimati).
Pertanto, secondo la suddetta circ. 12.8.2005 n. 38, è comunque necessario che i lavori di costruzione siano ultimati entro 3 anni dal momento della registrazione dell’atto di acquisto.
9 sanzioni amministrative
Gli atti irrogativi di sanzioni amministrative devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o entro il termine previsto per l’accertamento del tributo.
L’art. 20 del DLgs. 472/97 stabilisce che, per le sanzioni amministrative, l’atto di contestazione è notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi[69].
Detta norma ha rilievo autonomo nel caso di sanzioni non collegate in maniera diretta all’evasione, come nell’ipotesi di sanzioni concernenti il quadro RW[70].
Antecedentemente alle modifiche apportate dal DLgs. 99/2000, le sanzioni potevano essere irrogate anche nel “maggior” termine previsto per l’accertamento dei tributi, e non, come ora, nel “diverso” termine contemplato per questi ultimi.
Secondo l’Amministrazione finanziaria[71], la modifica normativa è indice della volontà del legislatore di evitare che, in comparti impositivi come l’imposta di registro, vi siano differenti termini di decadenza per l’atto di accertamento e per le sanzioni, sicché, allo stato attuale, ove per il tributo siano contemplati termini di decadenza inferiori al quinquennio, questi dovrebbero valere anche per le sanzioni.
10 cartelle di pagamento
La cartella di pagamento, al pari degli avvisi di accertamento, deve essere notificata entro termini decadenziali, previsti, per le imposte sui redditi e per l’IVA, dall’art. 25 del DPR 602/73.
Nel sistema attuale, anche la fase di riscossione è soggetta a termini decadenziali, con specifico riferimento alla cartella di pagamento.
Quindi, solo dopo la notifica del suddetto provvedimento trovano applicazione i termini di prescrizione, entro i quali, salvo eventi interruttivi, deve essere notificato il pignoramento[72].
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
- secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo[73];
- terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
- quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73[74].
Entro il 31.12.2013, pertanto, devono essere notificate la cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta:
- 2009, per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica;
- 2008, per le attività di controllo formale.
Invece, per le società che non hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine decorre non dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione, bensì da quello di “scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata”.
Dilazione a seguito di liquidazione automatica/controllo formale
Qualora, in caso di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione o di somme liquidate a seguito di tassazione separata, il contribuente si avvalga del versamento dilazionato degli importi richiesti con l’avviso bonario, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo[75].
Ciò, pertanto, vale anche nel caso in cui, dopo aver optato per la dilazione, il contribuente non abbia potuto onorare la prima rata[76].
Sebbene non sia previsto espressamente, il termine dovrebbe avere natura decadenziale, in quanto tutta l’attività di riscossione delle imposte è soggetta a termini di decadenza, per cui è da escludere la semplice natura ordinatoria del termine.
10.1 cartella di pagamento emessa a seguito di sentenza
L’art. 25 del DPR 602/73, per le imposte sui redditi (applicabile anche all’IVA e all’IRAP) stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Quindi, se l’atto viene impugnato, e la sentenza di rigetto, per ipotesi, passa in giudicato nel 2011, il termine di notifica della cartella di pagamento per l’IVA è il 31.12.2013.
È interessante notare che, secondo C.T. Reg. Bologna 4.2.2011 n. 17, in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività, il termine deve essere computato in relazione alla data in cui sono spirati i termini per l’impugnazione, e non con riferimento alla data in cui è passata in giudicato la pronuncia che ha dichiarato l’inammissibilità del gravame.
Sul punto è anche intervenuta la Corte di Cassazione, specificando però che, nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il dies a quo non è rinvenibile nel momento in cui sono spirati i termini per il ricorso, in quanto “deve ritenersi che l’accertamento non possa considerarsi definitivo sino a quando vi sia la pendenza della lite ed il giudizio non si sia concluso con una esplicita pronuncia sia pure di inammissibilità ovvero di improcedibilità”[77].
Tali considerazioni potrebbero essere superate da un altro orientamento della Suprema Corte, secondo cui qualora le somme siano dovute a seguito di sentenza passata in giudicato, il titolo che legittima la riscossione non sarebbe più il ruolo ma la sentenza, con la conseguenza che opererebbe sempre il termine di prescrizione decennale[78].
Pertanto, adottando questa impostazione, il termine di decadenza biennale opera solo in caso di accertamento definitivo per omessa impugnazione, mentre quello prescrizionale opera qualora la debenza delle somme sia accertata con il giudicato.
Detta soluzione, a nostro avviso, non può essere condivisa, in ragione del fatto che il sistema tributario, specie dopo la riforma del DLgs. 26.2.99 n. 46, contempla termini esclusivamente decadenziali tanto per l’accertamento quanto per la riscossione. La prescrizione, infatti, entra in gioco in momenti successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’inizio dell’espropriazione se si verte in ipotesi di accertamenti “esecutivi”.
Tra l’altro, anche parte della giurisprudenza di merito ha contrastato detto orientamento, specificando che non vi è ragione di differenziare la causa per cui l’accertamento è divenuto definitivo[79].
Si aggiunge che la tesi della Cassazione comporta problemi qualora il giudicato si sia formato su questioni processuali come l’inammissibilità del ricorso, ove non può sostenersi che la sentenza abbia statuito sul merito della pretesa. Comunque, dovrebbe rimanere fermo il termine di decadenza biennale nelle ipotesi in cui l’atto sia divenuto definitivo per estinzione del giudizio, come nell’omessa riassunzione del processo sospeso/interrotto.
La notifica tardiva della cartella di pagamento, ad ogni modo, comporta la nullità di tale atto, ma non travolge le iscrizioni a ruolo eseguite in via provvisoria nei momenti antecedenti[80].
10.2 Imposte indirette diverse dall’iva
Il termine decadenziale previsto dall’art. 25 del DPR 602/73 dovrebbe applicarsi anche alle imposte indirette. Nel senso dell’applicabilità del “vecchio” art. 17 del DPR 602/73 (relativo alla decadenza per l’iscrizione a ruolo) si sono pronunciate la C.T. Prov. Cagliari 23.1.2006 n. 298 e la C.T. Reg. Roma 26.2.2010 n. 42.
Come visto, Cass. 5.4.2013 n. 8380 ha però affermato, peraltro proprio in tema di imposte d’atto, che qualora la debenza delle somme sia accertata con sentenza passata in giudicato, opera la prescrizione decennale, contemplata, per l’imposta di registro, dall’art. 78 del DPR 131/86.
In linea generale, a nostro avviso la riforma del DLgs. 46/99 ha comportato l’abrogazione di tutte le norme preesistenti che prevedevano, per la notifica della cartella di pagamento, termini di prescrizione. Ora, dovrebbe sempre applicarsi la decadenza biennale di cui all’art. 25 del DPR 602/73, anche perché l’art. 19 del DLgs. 46/99, nell’elencare le norme del DPR 602/73 operanti solo per le imposte sui redditi, non richiama l’art. 25.
11 tabelle riepilogative
Di seguito si riportano, in forma tabellare, i termini di decadenza previsti per gli avvisi di accertamento e per le cartelle di pagamento, evidenziando altresì le cause di proroga.
Nelle seguenti tabelle vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento, in relazione alle varie annualità[81].
Avvisi di accertamento (dichiarazione presentata)
|
ANNO D’IMPOSTA |
ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
TERMINE ORDINARIO |
TERMINE PROROGATO AI SENSI DELLA |
TERMINE PROROGATO DAL DL 223/2006 (REATI)[83] |
TERMINE PROROGATO AI SENSI DELLA |
|
2001 |
2002 |
31.12.2006 |
31.12.2008 |
31.12.2010 |
31.12.2012 |
|
2002 |
2003 |
31.12.2007 |
31.12.2009 |
31.12.2011 |
31.12.2013 |
|
2003 |
2004 |
31.12.2008 |
31.12.2012 |
||
|
2004 |
2005 |
31.12.2009 |
31.12.2013 |
||
|
2005 |
2006 |
31.12.2010 |
31.12.2014 |
||
|
2006 |
2007 |
31.12.2011 |
31.12.2015 |
||
|
2007 |
2008 |
31.12.2012 |
31.12.2016 |
||
|
2008 |
2009 |
31.12.2013 |
31.12.2017 |
||
|
2009 |
2010 |
31.12.2014 |
31.12.2018 |
||
|
2010 |
2011 |
31.12.2015 |
31.12.2019 |
||
|
2011 |
2012 |
31.12.2016 |
31.12.2020 |
||
|
2012 |
2013 |
31.12.2017 |
31.12.2021 |
||
|
2013 |
2014 |
31.12.2018 |
31.12.2022 |
Avvisi di accertamento (dichiarazione omessa)
|
ANNO D’IMPOSTA |
ANNO IN CUI LA DICHIARAZIONE AVREBBE DOVUTO ESSERE PRESENTATA |
TERMINE ORDINARIO |
TERMINE PROROGATO AI SENSI DELLA |
TERMINE PROROGATO DAL DL 223/2006 (REATI)[86] |
TERMINE PROROGATO AI SENSI DELLA |
|
2000 |
2001 |
31.12.2006 |
31.12.2008 |
31.12.2011 |
31.12.2013 |
|
2001 |
2002 |
31.12.2007 |
31.12.2009 |
31.12.2012 |
31.12.2014 |
|
2002 |
2003 |
31.12.2008 |
–[88] |
31.12.2013 |
|
|
2003 |
2004 |
31.12.2009 |
31.12.2014 |
||
|
2004 |
2005 |
31.12.2010 |
31.12.2015 |
||
|
2005 |
2006 |
31.12.2011 |
31.12.2016 |
||
|
2006 |
2007 |
31.12.2012 |
31.12.2017 |
||
|
2007 |
2008 |
31.12.2013 |
31.12.2018 |
||
|
2008 |
2009 |
31.12.2014 |
31.12.2019 |
||
|
2009 |
2010 |
31.12.2015 |
31.12.2020 |
||
|
2010 |
2011 |
31.12.2016 |
31.12.2021 |
||
|
2011 |
2012 |
31.12.2017 |
31.12.2022 |
||
|
2012 |
2013 |
31.12.2018 |
31.12.2023 |
||
|
2013 |
2014 |
31.12.2019 |
31.12.2024 |
Termini di notifica delle cartelle di pagamento – Soggetti solari
| PERIODO D’IMPOSTA | TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE A RUOLO |
ANNO IN CUI È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE (O IN CUI L’ACCERTAMENTO È DIVENUTO DEFINITIVO) | TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO |
| 2006 | Accertamento definitivo | 2011 | 31.12.2013 |
| 2007 | Accertamento definitivo | 2011 | 31.12.2013 |
| 2008 | Accertamento definitivo | 2012 | 31.12.2014 |
| 2010 | Accertamento definitivo | 2013 | 31.12.2015 |
| 2008 | Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) |
2009 | 31.12.2013 |
| 2009 | Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/73) |
2010 | 31.12.2013 |
| 2009 | Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) |
2010 | 31.12.2014 |
| 2010 | Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/73) |
2011 | 31.12.2014 |
| 2010 | Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) |
2011 | 31.12.2015 |
| 2011 | Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/73) |
2012 | 31.12.2015 |
| 2011 | Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) |
2012 | 31.12.2016 |
| 2012 | Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/73) |
2013 | 31.12.2016 |
| 2012 | Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) |
2013 | 31.12.2017 |
| 2013 | Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/73) |
2014 | 31.12.2017 |
| 2013 | Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) |
2014 | 31.12.2018 |
Termini di notifica delle cartelle di pagamento – Soggetti non solari
Di seguito si propongono alcuni esempi di termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento in relazione alla liquidazione automatica di un contribuente con periodo d’imposta 1° aprile – 31 marzo.
| CHIUSURA DEL PERIODO D’IMPOSTA | PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE | EFFETTUAZIONE DELL’ULTIMO VERSAMENTO RATEALE | TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO |
| 31.3.2009 | 31.12.2009 | 16.2.2010 | 31.12.2013 |
| 31.3.2010 | 31.12.2010 | 16.2.2011 | 31.12.2014 |
| 31.3.2011 | 31.12.2011 | 16.2.2012 | 31.12.2015 |
| 31.3.2012 | 31.12.2012 | 16.2.2013 | 31.12.2016 |
| 31.3.2013 | 31.12.2013 | 16.2.2014 | 31.12.2017 |
[1] I termini decadenziali, invece, non possono mai essere interrotti: ciò in virtù dell’art. 2964 co. 1 c.c., secondo cui “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione”.
[2] La disciplina degli accertamenti “esecutivi” è contenuta nell’art. 29 co. 1 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni. L’espropriazione, in tale sistema di riscossione, deve essere disposta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo: da ciò consegue che il termine, avendo natura decadenziale, non può essere interrotto né da fermi di beni mobili registrati/iscrizioni ipotecarie né da intimazioni ad adempiere.
[3] Per effetto del disposto di cui all’art. 1 del DL 21.6.61 n. 498 conv. L. 28.7.61 n. 770, in presenza di eventi eccezionali non riconducibili a disfunzioni dell’Amministrazione, quest’ultima può emanare i c.d. “decreti di mancato o irregolare funzionamento dell’ufficio”, i quali comportano la sospensione dei termini scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento stesso. L’oggetto della trattazione non consente un adeguato approfondimento del tema, per cui in questa sede ci si limita ad affermare che, in presenza di determinati presupposti, i decreti possono essere disapplicati dal giudice, e devono essere adottati solo in situazioni eccezionali.
[4] Ai sensi dell’art. 10 della L. 289/2002, sono prorogati di due anni i termini accertativi in materia di imposte sui redditi e dell’IVA nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli artt. 7 (concordato per anni pregressi), 8 (integrativa semplice) e 9 (condono tombale) della L. 289/2002.
[5] Nelle notifiche eseguite a mezzo posta, l’art. 60 del DPR 600/73 prevede che la notifica, nei confronti del notificante, si perfeziona nel momento della spedizione.
[6] Da ultimo, si veda Cass. 26.3.2012 n. 4883.
[7] C.M. 17.5.2000 n. 98 (§ 8.1.1). Il Ministero afferma che un allungamento dei termini sarebbe illogico in quanto, nella fattispecie esaminata, si trattava di un’integrazione a favore dell’Erario. Pertanto, non è possibile escludere una diversa interpretazione ministeriale ove ci si riferisca a dichiarazioni a favore del contribuente.
[8] C.T. Prov. Siracusa 12.6.2012 n. 246 e 247/1/12.
[9] Art. 36 co. 3 lett. b) del DLgs. 241/97.
[10] I commi 1 lett. e) e 9 lett. b) dell’art. 10 del DL 201/2011 fanno espresso riferimento agli artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72, quindi, nell’ipotesi di omessa dichiarazione (disciplinata, invece, nel comma 2 delle predette norme) parrebbe rimanere fermo il termine ordinario, coincidente con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
[11] Quindi, il termine coinciderà con il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e non del sesto, siccome rimane fermo l’ordinario termine quadriennale, raddoppiato per effetto della presunta violazione penale.
[12] Art. 10 co. 1 – 8 del DL 201/2011.
[13] Art. 10 co. 9 – 13 del DL 201/2011.
[14] Alla luce di ciò, l’accertamento relativo all’anno 2011 non dovrà essere notificato entro il 31.12.2016, ma entro il 31.12.2015.
[15] Dal tenore letterale della norma, sembra che non abbia rilevanza la tipologia di condono a cui il contribuente aveva aderito, quindi si potrebbe spaziare dal c.d. “condono tombale” (art. 9 della L. 289/2002), alla “rottamazione dei ruoli” (art. 12 della L. 289/2002) sino alla definizione delle liti (art. 16 della L. 289/2002).
[16] Si tratta di una disposizione opposta a quella di cui all’art. 10 della L. 289/2002, ove era stata introdotta una proroga biennale nei confronti dei contribuenti che non avevano aderito ai condoni.
[17] In senso opposto, richiamando peraltro un passo della sentenza 247/2011 a nostro avviso poco inerente, si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 13.1.2012 n. 1. Secondo tale interpretazione, sarebbe possibile accertare il 2000 entro il 31.12.2012 per le omesse dichiarazioni, il 2001 entro il 31.12.2013 sempre per le omesse dichiarazioni e il 2002 entro il 31.12.2012 come sopra indicato.
[18] Ai sensi dell’art. 37 co. 26 del DL 223/2006 conv. L. 248/2006, la norma si applica a “decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini” per l’accertamento. Pertanto, la proroga non può, in virtù della suddetta disciplina transitoria, essere applicata in riferimento al 2000, siccome opera a partire dal 2001 (i cui termini, scadendo il 31.12.2006, erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del DL 223/2006, avvenuta il 4.7.2006).
[19] Corte Cost. 25.7.2011 n. 247.
[20] Si veda il precedente § 3.
[21] Si veda il successivo § 6.1.
[22] Il caso emblematico potrebbe essere la dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000), che, come prevede la norma, si concretizza quando l’indicazione in dichiarazione degli elementi fittizi comporti un’evasione superiore, “con riferimento a taluna delle singole imposte”, a 50.000,00 euro.
[23] Reato di cui all’art. 11 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214.
[24] Si evidenzia che, per le sanzioni relative al modulo RW, il termine, ai sensi dell’art. 12 del DL 78/2009, è raddoppiato se la violazione si riferisce ad attività finanziarie e/o investimenti detenuti in “paradisi fiscali” (si veda il successivo § 5).
[25] Si vedano C.T. Prov. Bergamo 17.12.2012 n. 137/2/13 e C.T. Prov. Massa Carrara 17.2.2011 n. 74/1/11.
[26] Art. 10 co. 6 della L. 8.5.98 n. 146.
[27] Sentenza 11.12.2012 n. 22587.
[28] Si vedano C.T. Prov. Reggio Emilia 19.9.2012 n. 115/4/12, C.T. Prov. Ancona 22.5.2013 n. 152/2/13 e C.T. Prov. Treviso 6.5.2013 n. 38/4/13.
[29] Ciò porta ad affermare la necessità che, nel caso in cui l’atto venga notificato nel termine “lungo”, già nell’accertamento siano contenute le ragioni per cui si ritiene operante la proroga, ragioni che dovranno esternarsi in rilievi puntuali sulla condotta del contribuente, e non in tautologiche affermazioni quali “si ritiene che la fattispecie integri la dichiarazione infedele”.
Nel senso che la mancata spiegazione sulla notifica “tardiva” dell’atto si traduce in un vizio di motivazione, si veda C.T. Prov. Varese 18.2.2013 n. 22/1/13.
[30] Fattispecie che, in ambito penale, fa venire meno il reato ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 74/2000, ma che, in ambito tributario, ha effetti solo sull’inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 546/92.
[31] C.T. Prov. Milano 26.9.2011 n. 231/40/11.
[32] C.T. Prov. Siracusa 12.6.2012 n. 246 e 247/1/12.
[33] C.T. Prov. Torino 8.6.2011 n. 97/15/11.
[34] C.T. Prov. Palermo sez. Catania 4.5.2012 n. 73/18/12.
[35] Si vedano C.T. Prov. Milano 12.12.2011 n. 372/3/11 e 26.9.2011 n. 231/40/11, C.T. Prov. Brescia 10.4.2012
n. 40/16/12; C.T. Prov. Lecco 19.6.2012 n. 74/1/12 e C.T. Reg. Bari 11.10.2013 n. 68/8/13; contra C.T. Prov. Reggio Emilia 19.9.2012 n. 115/4/12.
[36] Consiglio di Stato 10.8.2011 n. 4769.
[37] Questa pronuncia desta molto interesse, poiché i giudici hanno, in sostanza, affermato che quanto esposto non si pone in contrasto con il “doppio binario”, siccome detto principio deve essere interpretato nel senso che se un fatto non costituisce reato non sussiste nemmeno l’obbligo di invio della denuncia. Non è, inoltre, possibile ritenere che l’organo verificatore sia libero di definire o meno il rilievo penale di una condotta, “come – in ultima analisi – non si può ritenere lo stesso fatto penalmente irrilevante sul piano oggettivo ed invece rilevante sul piano soggettivo (cioè della personale convinzione dell’ufficio)”.
[38] Vedasi, però, Cass. 11.12.2012 n. 22587, secondo cui il raddoppio riguarda anche gli accertamenti ove vengono disconosciuti i crediti IVA, e C.T. Prov. Varese 18.2.2013 n. 22/1/13, ove i giudici hanno affermato che, se viene contestato l’art. 3 del DLgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), si deve necessariamente trattare di un contribuente soggetto all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, e non di un lavoratore dipendente, stante il carattere “proprio” del reato.
[39] Circ. 29.12.2008 n. 1, Parte VII, cap. 4.
[40] Studio 8/2010.
[41] Artt. 8 e 10 del DLgs. 74/2000.
[42] Art. 10-bis del DLgs. 74/2000.
[43] Il problema potrebbe porsi in tema di redditi di lavoro dipendente, ove l’Agenzia delle Entrate, con una prassi avallata dalla Cassazione, può accertare, ad esempio nel “lavoro nero”, sia il sostituto sia il sostituito.
[44] Art. 10 del DLgs. 74/2000.
[45] Art. 11 del DLgs. 74/2000.
[46] Per le società di capitali trasparenti, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 23.12.2009 n. 54), il rinvenimento di elementi penalmente rilevanti durante un controllo a carico della società, comporterebbe il raddoppio anche nei confronti dei soci.
[47] Anche la giurisprudenza penale ha sancito che la trasparenza opera, in sostanza, in ambito tributario e non in ambito penale (si vedano Cass. 18.5.87 n. 454 e 5.7.91 n. 7167).
[48] C.T. Prov. Brindisi 10.10.2011 n. 194/3/11.
[49] Art. 127 del TUIR.
[50] Art. 115 del TUIR.
[51] Art. 73 co. 3 del DPR 633/72.
[52] Tale impostazione deriva dalla lettura di una previsione analoga contenuta nel DL 223/2006, con la quale sono stati raddoppiati i termini di accertamento in presenza di violazione che comporta l’obbligo di denuncia in base all’art. 331 c.p.p. (si veda il precedente § 4). In tale circostanza, è stato infatti stabilito che il raddoppio dei termini opera per i periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso DL 223/2006, risultavano ancora pendenti i termini per l’accertamento (art. 37 co. 26 del DL 223/2006).
[53] Si vedano C.T. Prov. Lucca 18.7.2012 n. 103/4/12 e C.T. Prov. Vicenza 18.6.2012 n. 61/3/12.
[54] L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Se l’ammontare dei crediti indebitamente compensati risulta superiore a 50.000,00 euro per ciascun anno solare, la sanzione è del 200% della misura dei crediti utilizzati. Nelle suddette ipotesi, non è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni (art. 27 co. 18 del DL 185/2008).
[55] I nuovi termini si applicano a decorrere dalla data di presentazione del modello F24 nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali, al 29.11.2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008), siano ancora pendenti gli ordinari termini di decadenza dal potere di accertamento. Pertanto, il termine di otto anni riguarda anche i crediti inesistenti utilizzati in compensazione nell’anno 2003, essendo ancora pendente, alla data del 29.11.2008, il termine per l’accertamento di tale annualità.
La disposizione prevede che restano ferme le proroghe dei termini in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia per il reato di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 (si veda il precedente § 4).
[56] Le somme pretese, come previsto dal co. 19 dell’art. 27 del DL 185/2008, verrebbero iscritte nei ruoli straordinari (art. 15-bis del DPR 602/73), il che comporterebbe l’inapplicabilità della riscossione frazionata.
[57] Nella videoconferenza tenutasi il 17.1.2009, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che per “crediti inesistenti” devono intendersi sia quelli artificiosamente rappresentati in sede contabile o dichiarativa, sia quelli ritenuti tali a causa di errate valutazioni del contribuente.
[58] C.T. Prov. Lecce 29.1.2013 n. 13/2/13.
[59] La natura accertativa di detti provvedimenti è pacifica in giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. 22.3.2011 n. 6582 e 3.11.2010 n. 22322).
[60] Art. 76 co. 1 del DPR 131/86.
[61] Art. 76 co. 1-bis del DPR 131/86.
[62] Art. 76 co. 2 del DPR 131/86.
[63] Art. 17 del DLgs. 347/90.
[64] Art. 1 co. 161 della L. 296/2006.
[65] Art. 1 co. 163 della L. 296/2006. Vedasi però quanto affermato nel successivo § 10.1, in tema di notifica della cartella di pagamento a seguito di sentenza del giudice tributario.
[66] Infatti, come specificato nella circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2001 n. 19, non è possibile fare riferimento alle indicazioni fornite dall’art. 76 del DPR 131/86, poiché questa disposizione regola ipotesi di liquidazione delle imposte principale e suppletiva, mentre l’imposta dovuta a seguito di decadenza dall’agevolazione “prima casa” ha natura complementare.
[67] Cass. 24.4.2009 n. 9776.
[68] Circ. Agenzia delle Entrate 14.8.2002 n. 69 e 12.8.2005 n. 38 (§ 5).
[69] Le norme antecedenti alla riforma operata dai DLgs. 471, 472 e 473 del 1997, contrastanti con l’art. 20 del DLgs. 472/97, si ritengono implicitamente abrogate ai sensi dell’art. 29 dello stesso DLgs. 472/97. Si pensi all’art. 76 co. 4 del DPR 131/86, secondo cui la soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, “nel termine stabilito per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono”.
[70] Infatti, ora l’art. 17 del DLgs. 472/97, dopo le modifiche apportate dal DL 98/2011, prevede espressamente che le sanzioni collegate al tributo debbano essere irrogate unitamente all’accertamento.
[71] C.M. 5.7.2000 n. 138/E (§ 2.4).
[72] L’asserita natura prescrizionale del termine per disporre il pignoramento non è applicabile nell’attuale sistema degli accertamenti esecutivi. Infatti, l’art. 29 del DL 78/2010 stabilisce che, in questo caso, l’espropriazione deve iniziare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
[73] In merito alle parti di atto divenute definitive per mancata impugnazione, il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento decorre dalla data in cui sono spirati i sessanta giorni per l’impugnazione dell’atto (C.T. Reg. Trieste 9.6.2011 n. 70/10/11), e lo stesso discorso vale per il giudicato “interno”, ove il termine decorre dalla data della sua formazione (Cass. 23.2.2007 n. 4257 e Cass. 20.2.2013 n. 4172).
[74] Per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 (Indennità di fine rapporto) e 20 del TUIR (Prestazioni pensionistiche), la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta. L’art. 20 del TUIR, relativo alle prestazioni pensionistiche complementari, è stato abrogato dall’art. 21 co. 3 lett. c) del DLgs. 252/2005, a decorrere dall’1.1.2007. Tale disciplina continua però a trovare applicazione con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari maturate fino al 31.12.2006. Per le prestazioni maturate dall’1.1.2007, la tassazione avviene mediante ritenuta a titolo d’imposta.
[75] Art. 3-bis del DLgs. 462/97.
[76] In questa ipotesi, di conseguenza, troverebbe applicazione non il termine di cui all’art. 25 del DPR 602/73, ma quello disciplinato dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97.
[77] Cass. 27.3.2013 n. 7690.
A nostro avviso, in caso di estinzione del processo per inattività delle parti, il dies a quo dovrebbe coincidere con il momento in cui sono spirati i termini per la riassunzione, e non con la data di eventuale dichiarazione del giudice sull’intervenuta estinzione, posto che questa opera di diritto.
[78] Si vedano Cass. 5.4.2013 n. 8380 e Cass. 19.7.2013 n. 17669.
[79] C.T. Reg. Roma 30.10.2012 n. 103/20/12.
[80] Cass. 8.5.2000 n. 5765.
[81] Si evidenzia che, in base all’art. 2 co. 5-ter del DL 13.8.2011 n. 138 conv. L. 14.9.2011 n. 148, con riferimento all’IVA e solo per i soggetti che hanno aderito ai condoni di cui alla L. 27.12.2002 n. 289, i termini di decadenza per l’accertamento pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di un anno.
[82] Per i periodi d’imposta condonabili, la mancata adesione ai condoni di cui alla L. 27.12.2002 n. 289 comporta la proroga biennale dei termini.
[83] In ipotesi di violazioni penalmente rilevanti, i termini per l’accertamento sono raddoppiati con riferimento all’anno in cui la suddetta violazione è stata commessa.
[84] Nelle tabelle, per comodità espositiva, si è deciso di evidenziare il termine derivante dal cumulo tra la proroga per la mancata adesione ai condoni di cui alla L. 27.12.2002 n. 289 e il raddoppio per reati fiscali, che, però, è stato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza 25.7.2011 n. 247).
[85] Per i periodi d’imposta condonabili, la mancata adesione ai condoni di cui alla L. 27.12.2002 n. 289 comporta la proroga biennale dei termini.
[86] In ipotesi di violazioni penalmente rilevanti, i termini per l’accertamento sono raddoppiati con riferimento all’anno in cui la suddetta violazione è stata commessa.
[87] Nella tabella, per comodità espositiva, si è deciso di evidenziare il termine derivante dal cumulo tra la proroga per la mancata adesione ai condoni di cui alla L. 27.12.2002 n. 289 e il raddoppio per reati fiscali, che, però, è stato giudicato illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza 25.7.2011 n. 247).
[88] L’art. 2 co. 44 lett. f) della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004) prevede che la proroga biennale dei termini ha effetto anche nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono dei condoni per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2002. Al riguardo, la norma citata prevedeva che le disposizioni sui condoni potessero applicarsi anche relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2002, “per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003”. Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, “resta inteso che i termini dell’accertamento relativo al periodo d’imposta 2002, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, non sono suscettibili di proroga, posto che … in tal caso [quello di omessa presentazione della dichiarazione, n.d.a.] viene meno la possibilità di avvalersi della definizione e, quindi, la stessa ratio della norma in commento” (circ. Agenzia delle Entrate 18.2.2004 n. 7, § 3.6).

